Egitto Tra le Dita
Intro
SABBIA
Capitolo 0
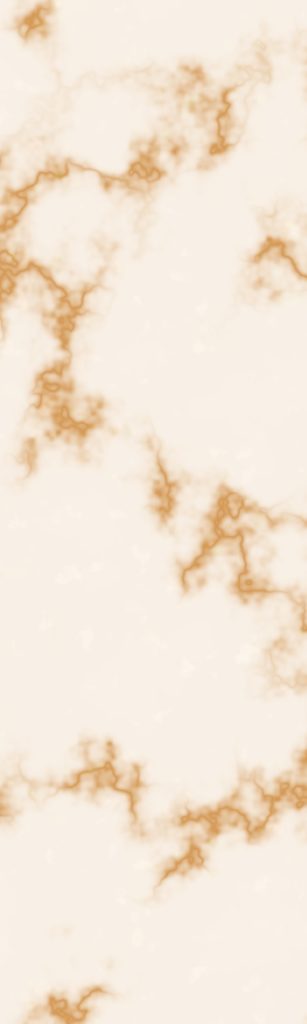
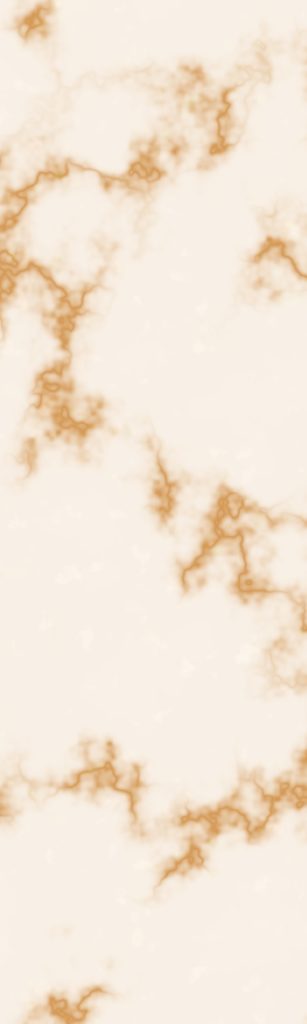
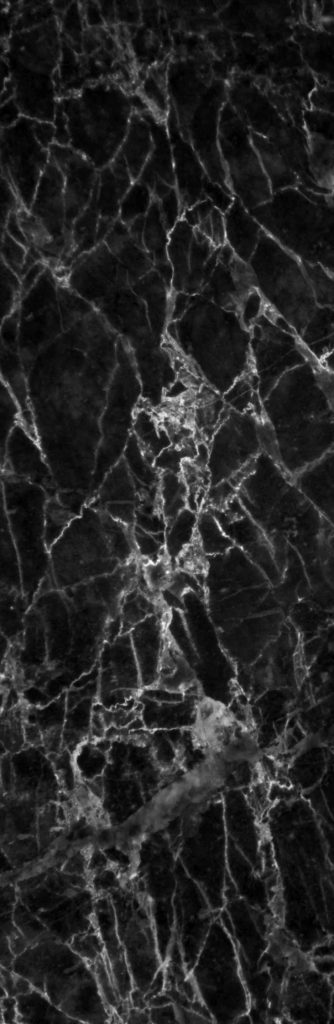
L’impiegato raccoglie i soldi e mi consegna un adesivo verdino, grande quanto una figurina. Mugugno un “thanks” e procedo verso il controllo immigrazione, il battito cardiaco sempre più in tiro.
Mi metto in fila, aspetto il mio turno. L’ufficiale dell’immigrazione fa cenno di avvicinarmi. Procedo con lentezza, dimostro una calma che non ho. Gli regalo un sorriso tirato e appoggio visto e passaporto sul davanzale del gabbiotto. Nota il tremore nelle mie mani. Mi fissa negli occhi. Rispondo con un debole sorriso. Senza staccarmi gli occhi di dosso, afferra il passaporto e lo sfoglia. Uno, due, tre, dieci volte. Alza gli occhi dal documento. Un’altra occhiata penetrante. Una vampata di agitazione mi infiamma il petto.
Sta a vedere che qua finisce come alla dogana in Marocco…
“Can you stand there, please?” indica il lato della sala dove tutti gli altri passeggeri stanno facendo la fila. Non faccio in tempo a rispondere che se ne va con il passaporto, scomparendo nei meandri dell’aeroporto.
Colombia, Cuba, Ecuador…
Ripasso i visti sul documento.
Nessuno di questi dovrebbe presentare problemi. Che altro c’è… Marocco, Turchia…bah!
L’agente ritorna senza il passaporto, si accomoda nel gabbiotto e fa segno al primo della fila di avvicinarsi. “Next!” e indica un altro passeggero. Un altro. E a un altro ancora. Perdo il conto.
Il tremore alle mani diventa incontrollabile. Deglutisco a fatica, la gola è diventata un barile di sabbia. Un altro agente si avvicina al gabbiotto con in mano un passaporto rosso bordeaux e scambia due parole con l’ufficiale. Mi fa segno di avvicinarmi. Mi accosto al bancone, il battito cardiaco aumenta di velocità.
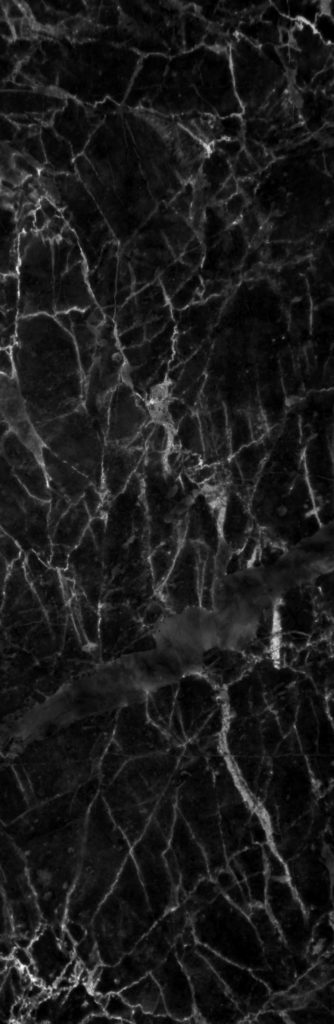

Mi mordo un’unghia, mi gratto un sopracciglio.


“Hello?” una voce nota risuona alle mie spalle.
Mi giro. Davanti a me c’è lo stesso signore di prima, stavolta accompagnato da altri due uomini dallo sguardo di ferro. Esibisce un tesserino scritto in arabo.
